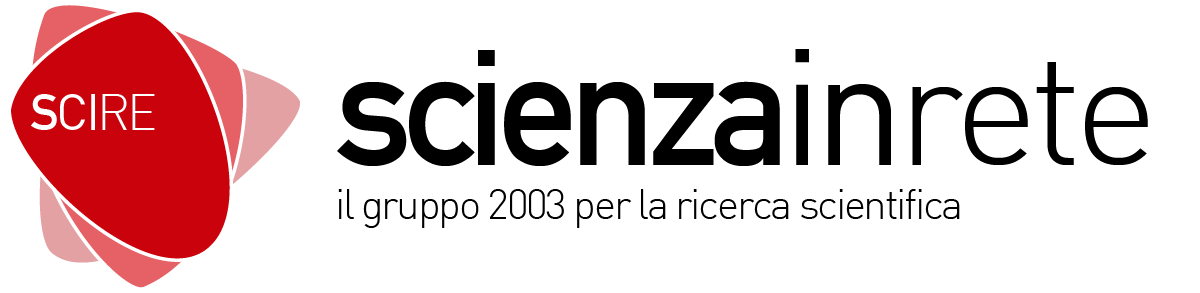Francesco Sylos Labini

Fisico. La sua attività di ricerca include: fisica statistica, la cosmologia, la dinamica gravitazionale. Ha pubblicato circa 70 articoli in riviste internazionali e di circa 40 contributi per conferenze internazionali. E' co-autore del libro Statistical Physics for Cosmic Structures (Springer Verlag 2005). E' anche editor di Dinamica e termodinamica di sistemi con a lungo raggio interazioni: teoria ed esperimenti (AIP, 2008).
Attualmente è ricercatore presso l'Istituto per i Sistemi Complessi del Consiglio Nazionale delle Ricerche. E' inoltre visiting professor presso il Dipartimento di Fisica della Università Cattolica degli Studi di Brescia, dove insegna Astrofisica.
di Francesco Sylos Labini, Francesca Coin
14 Jan 2013