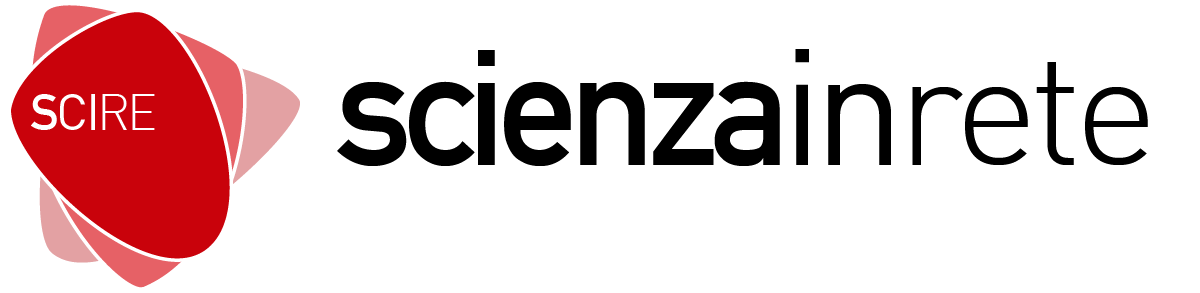Uno studio appena pubblicato sul New England Journal of Medicine evidenzia per la prima volta la presenza di micro- e nanoplastiche nelle placche aterosclerotiche di pazienti sottoposti a intervento chirurgico. Seguendo i pazienti per i 34 mesi successivi, il gruppo di ricerca ha potuto rilevare anche un maggior rischio di malattia cardiovascolare nei pazienti in cui erano state rilevate le microplastiche rispetto a coloro che invece non le avevano accumulate, e l’aumento di alcune molecole associate all’infiammazione
Che la plastica costituisca un enorme problema ambientale è ormai del tutto riconosciuto; così come sono riconosciuti i danni che causa a molte specie, soprattutto marine, che finiscono intrappolate da frammenti di reti, o i cui stomaci sono così pieni di rifiuti da impedire loro di alimentarsi. È anche del tutto noto che le plastiche sono ubiquitarie: non solo sono ormai presenti in ogni ambiente, anche dove non vi sono sostanzialmente attività antropiche, ma frammenti più piccoli, quelli detti micro- e nanoplastiche, sono stati rilevati in svariati tessuti umani, dai polmoni alla placenta.
Così, l’avvertimento dei possibili effetti dannosi anche per la salute umana si moltiplicano, e sono numerosi gli studi per indagarli. Tuttavia, i dati disponibili sono molto limitati, e rendono difficile stabilire con chiarezza gli effetti clinici delle plastiche sulla salute umana: ora, però, uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine e guidato da medici e ricercatori dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, riesce a stabilire per la prima volta la correlazione tra la presenza di plastiche nell’organismo umano e aumento del rischio cardiovascolare.
Plastica e salute umana: cosa sappiamo
«Il peso delle prove scientifiche fornite dagli attuali dati sugli effetti avversi di micro- e nanoplastiche sulla salute umana è scarso, a causa delle limitazioni sostanziali delle informazioni disponibili», scrive il report dell’Organizzazione mondiale della sanità dedicato all’esposizione alla plastica e alle possibili implicazioni per la nostra salute, pubblicato nel 2022. Parte del problema è legato alla mancanza di metodi standardizzati per le indagini, cui si uniscono una serie di altri limiti: per esempio, la difficoltà a combinare le informazioni sull’esposizione alla plastica con quelle sulla tossicità, perché gli studi sulla presenza di plastiche nelle bevande o nel cibo tendono a rilevare particelle relativamente grandi, mentre gli studi tossicologici si concentrano sulle microparticelle che possono essere assorbite dall’organismo.
Stanno, comunque, emergendo alcuni effetti della plastica nell’organismo: studi in vitro e su modelli animali hanno evidenziato come questi materiali possano causare stress ossidativo e infiammazione; uno studio del 2021, condotto su membrane lipidiche che simulano quelle cellulari ne ha evidenziato anche un possibile danno meccanico diretto. Soprattutto, sappiamo che molte delle sostanze usate come additivi per i prodotti in plastica, usati come ritardanti di fiamma, per renderle più stabili o flessibili, per influenzarne la resistenza ai raggi UV eccetera, sono possono avere effetti neurotossici, cancerogeni e d’interferenza endocrina. È il caso, per esempio, del bisfenolo A, il cui uso in alcuni ambiti (come quello cosmetico o la produzione di biberon) è infatti oggi vietato nell’Unione europea. Ancora, nel 2023 uno studio negli uccelli marini ha portato a coniare un nuovo termine, “plasticosi”, a indicare l’effetto di fibrosi che si verifica nel proventricolo di questi animali a seguito dell’ingestione di plastica.
Sono informazioni già di per loro inquietanti, tanto più se si considera che un altro aspetto ormai ben noto delle plastiche, e soprattutto delle particelle più piccole, quelle note come micro- e nanoplastiche, è che si possono accumulare in moltissimi tessuti umani. Gli studi ne hanno evidenziato la presenza nel circolo sanguigno, nel fegato, nei polmoni, nel colon, perfino nella placenta. E, tuttavia, cosa la loro presenza significhi in termini clinici non è ancora chiaro: le particelle di plastica sono presenti, sì, ma cosa implica la loro presenza?
I rapporti tra plastiche, infiammazione e rischio cardiovascolare
Il nuovo studio inizia proprio a rispondere a questa domanda. Gli autori hanno analizzato 257 pazienti che si sono dovuti sottoporre a endoarterectomia carotidea, un intervento che consiste della rimozione di placche aterosclerotiche che, restringendo il lume dei vasi, limitano l’apporto di sangue al cervello. Le analisi delle placche rimosse hanno rilevato quello che rappresenta il primo importante risultato del lavoro: «Per il 58% dei pazienti, le placche contenevano micro- e nanoplastiche – e soprattutto queste ultime, a ulteriore conferma del fatto che l’assorbimento di queste particelle aumenta al diminuire della loro dimensione», spiega Raffaele Marfella, primo autore dell’articolo, medico internista e professore ordinario all’Università della Campania Luigi Vanvitelli.
Il gruppo di ricerca non si è fermato alla constatazione della presenza di queste particelle, rappresentate per lo più da polietilene e polivinilcloruro, ma ha anche cercato di capirne il significato clinico. «Da molti anni lavoriamo con pazienti ad alto rischio cardiovascolare. Ci siamo resi conto come, pur migliorando molti dei parametri associati a un rischio aumentato, come il diabete e l’ipertensione, rimanga una certa percentuale di rischio residuo, intorno al 30%, che non riusciamo a spiegare», racconta Marfella. «Data la riconosciuta ubiquità della plastica, ci siamo chiesti se questo materiale potesse avere un ruolo».
Così, i ricercatori hanno analizzato i dati dei pazienti operati, e si sono accorti che proprio i pazienti nelle cui placche erano state rilevate le micro- e nanoplastiche erano anche coloro nei quali si rilevava una maggior incidenza di ictus, infarto miocardico e morte nei 34 mesi successivi di follow up. «Abbiamo insomma potuto evidenziare una correlazione clinica tra l’accumulo di plastica e un aumento del rischio cardio-vascolare. Quindi, per cercare di valutare, sebbene in modo indiretto, il meccanismo alla base di questo aumentato rischio, abbiamo indagato alcuni parametri associati all’infiammazione», spiega Marfella. «In effetti, i nostri risultati mostrano come, sempre nei pazienti in cui sono state trovate le micro- e nanoplastiche, si riscontrino anche livelli più elevati di specifiche interleuchine e altre proteine associate alla presenza di infiammazione».
«Questo dato ci dà contezza di un possibile meccanismo patogenetico delle plastiche, basato appunto sull’infiammazione», continua il professore. «Infatti, micro- e nanoplastiche sono facilmente assorbite dall’organismo, che però non è in grado di degradarle. L’accumulo di questo materiale estraneo rappresenta un continuo stimolo infiammatorio e questo, a sua volta, ha un ruolo importante nelle patologie cardiovascolari. L’infiammazione, infatti, è nota per essere un importante fattore di progressione dell’aterosclerosi e delle sue complicanze. Per esempio, rende le placche più prone alla rottura, che causa la formazione di trombi».
Domande aperte e direzioni certe
È importante sottolineare, come fanno gli stessi autori e autrici nel loro articolo, che lo studio rientra nel vecchio adagio correlation is not causation. La correlazione tra la presenza di plastica nelle placche e l’aumento del rischio cardiovascolare non prova che ne sia la causa: possono entrare in gioco altre variabili, comprese lo stato generale di salute o l’esposizione a inquinanti quali i PM10 e PM2.5. Tuttavia, lo studio ha il grande merito di puntare il riflettore su una correlazione la cui rilevanza apre la strada a studi mirati, per capire se in effetti le plastiche possano essere considerate fattori di rischio cardiovascolari, quali altri organi potrebbero risentirne, e come.
«Diventa anche sempre più importante capire come possiamo ridurre l’esposizione a micro- e nanoplastiche. Nel nostro lavoro ci sono alcuni limiti: per esempio, non abbiamo potuto indagare la presenza di additivi associati alle plastiche, troppo complesso dal punto di vista tecnico; né abbiamo valutato da dove derivassero le plastiche rilevate nei pazienti, anche se l’ipotesi è che provengano soprattutto da acqua e alimentazione», specifica Marfella. «Inoltre, noi stessi stiamo ora cercando di raccogliere maggiori dati per capire quanta plastica è necessario si accumuli perché possa diventare un fattore di rischio, e per quanto tempo deve permanere nell’organismo».
I risultati dello studio aprono, insomma, una vasta serie di domande. Allo stesso tempo, sono un’ulteriore conferma di quella che è da tempo una certezza: dobbiamo cambiare, e in fretta, il nostro rapporto (in termini di produzione, uso e smaltimento) con la plastica. Cosa possono fare, si chiede l’editoriale del New England Journal pubblicato in concomitanza con lo studio, i medici e gli operatori del settore sanitario? Innanzitutto riconoscere che i costi contenuti e la convenienza dei prodotti in plastica mascherano rischi più grandi; incoraggiare una riduzione del loro uso, sia nei singoli sia a livello istituzionale; e poi esprimere il massimo supporto per il Global Plastics Treaty, l’accordo internazionale, legalmente vincolante, per la riduzione dell’inquinamento da plastica proposto dalle Nazioni Unite e tutt’oggi in discussione – purtroppo, finora, con risultati limitati.
Indicazioni senz’altro valide anche al di fuori del settore medico. Perché certo, in un mondo che vede la crescita della plastica progredire di pari passo con le prove dei suoi danni, non si può non sottoscrivere la conclusione dell’editoriale: «Inaction is no longer an option», l’inerzia non è più un’opzione.