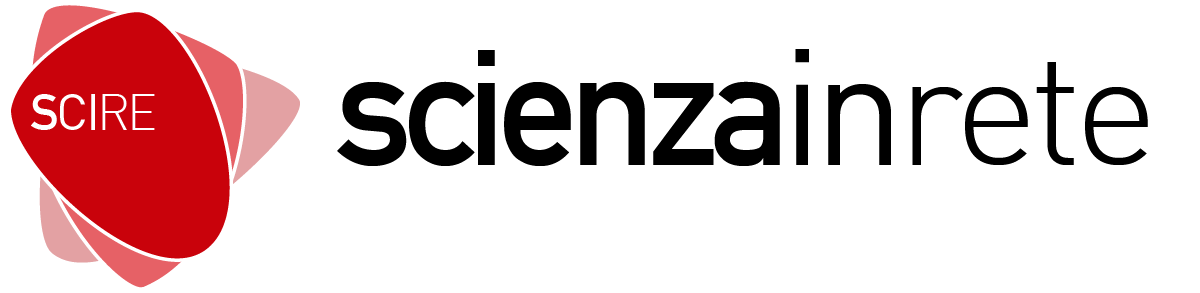Immagine da pxfuel.
Qualche settimana fa, una delle nostre autrici ci ha chiesto di aggiungere al suo profilo i suoi pronomi di genere, “she/her”. Si tratta di Katinka Bellomo, ricercatrice del Politecnico di Torino, che ha scritto per noi un articolo su una recente ricerca che ha coordinato riguardo alle sorgenti dell’incertezza sulle previsioni del clima in Europa. «Normalizzare l'uso dei pronomi di genere in ogni tipo di interazione sociale permette a tutte le persone di poter dichiarare la propria identità di genere, che non sempre corrisponde al sesso biologico assegnato alla nascita, senza imbarazzo o paura di ritorsioni», spiega Bellomo. «Inoltre, credo che l'uso dei pronomi aiuti ad abbattere gli stereotipi di genere e dunque diminuire la pressione a conformarsi ad essi. Per esempio, intraprendere una carriera piuttosto che un'altra, desiderare o meno di avere una famiglia, o semplicemente come vestirsi ogni mattina. Se si slegassero queste scelte di vita dal sesso biologico, ci sarebbe più uguaglianza», aggiunge.
Dalla sua richiesta è nato un confronto interno alla redazione riguardo all’attenzione che diamo ai temi della discriminazione di genere e dei diritti LGBTQ+. Se da una parte siamo attenti a usare un linguaggio che non discrimini le donne e le ricercatrici, non abbiamo mai parlato esplicitamente delle difficoltà che le persone della comunità LGBTQ+ incontrano in ambito accademico e in particolare nelle discipline dell’area STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Lo facciamo oggi intervistando Alfredo Carpineti, astrofisico, giornalista scientifico, podcaster e fondatore dell’associazione britannica Pride In STEM.
Com’è nata l’idea di fondare l’associazione Pride in STEM?
Nel 2016, con un gruppo di amici, attivisti e scienziati volevamo partecipare al Pride qui a Londra e per farlo era necessario avere un sito web e un indirizzo di posta elettronica, per permettere ad altri di unirsi al proprio gruppo durante la manifestazione. In breve tempo ci hanno contattato università e industrie del settore STEM per chiederci consigli e informazioni su come migliorare la condizione delle persone LGBTQ+ nella loro organizzazione. Ci siamo resi conto che c’era un grande bisogno di avere risorse in modo centralizzato. Abbiamo quindi contattato le organizzazioni di beneficenza che lavorano sui diritti LGBTQ+ nel Regno Unito (con alcune delle quali avevo personalmente collaborato in precedenza) e abbiamo cominciato a progettare un piano per la nostra associazione. Abbiamo capito ben presto che quello che potevamo fare meglio, dato che siamo un’organizzazione molto seguita ma molto piccola – solo nove persone, era essere una piattaforma per dare visibilità alle persone LGBTQ+ nel mondo scientifico, permettergli di parlare della loro ricerca e della loro esperienza e delle difficoltà nel mondo STEM. Questa rimane l’attività centrale di Pride in STEM.
In che modo vi proponete come piattaforma di comunicazione per i ricercatori LGBTQ+?
Soprattutto attraverso gli eventi che abbiamo chiamato Out Thinkers, in cui i ricercatori per qualche minuto parlano della loro esperienza e poi raccontano della loro attività di ricerca. Venerdì 9 luglio, per esempio, abbiamo organizzato un evento per il Festival della scienza di Edimburgo, in cui tre ricercatori LGBTQ+ hanno parlato di come molte discussioni sul cambiamento climatico non prendano in giusta considerazione le comunità, soprattutto di colore e di minoranze, che subiscono maggiormente gli impatti del cambiamento climatico.
Quali sono le altre attività della vostra associazione?
Recentemente abbiamo partecipato al lavoro di un gruppo di parlamentari britannici provenienti da diversi partiti che si è concentrato sull’equità all’interno della forza lavoro nell’area STEM. Si tratta dei cosiddetti All-Party Parliamentary Group, dei gruppi di membri delle due camere che si riuniscono per approfondire e raccogliere dati su temi specifici senza un obiettivo legislativo immediato. Nel contribuire al lavoro di questo gruppo, abbiamo incluso anche dati riguardo la situazione del mondo accademico su parità di genere, discriminazione verso persone di colore, disabili o di livello socioeconomico svantaggiato. Questo perché donne, persone di colore, disabili o che provengono da contesti socioeconomici svantaggiati fanno anche loro parte della comunità LGBTQ+. La battaglia per i diritti delle minoranze è una sola battaglia.
Come viene percepita questa battaglia all’interno del mondo accademico, e scientifico in particolare?
In alcuni ambienti si tende a pensare che gli scienziati si interessino solo di scienza, ma non è vero. Il confirmation bias ci riguarda tutti, fa parte del modo in cui evolve il nostro cervello. Quando vediamo qualcosa che contraddice la nostra visione del mondo, tendiamo a pensare che sia sbagliata. Ma quando questa cosa riguarda l’identità degli altri dobbiamo fare un passo indietro e metterci nei loro panni. Trovo, inoltre, che il modo di insegnare la scienza in ambito universitario non alleni in questo senso. Per esempio, in nove anni di studio dell’astrofisica, dalla triennale al dottorato, non mi è mai stata descritta alcuna teoria alternativa alla materia oscura. Eppure, esistono teorie alternative, seppure reputate molto meno probabili, ma sono semplicemente omesse. Vedo una contraddizione in questo approccio all’insegnamento: da una parte si chiede a chi fa ricerca di mantenere la mente aperta, dall’altro si spinge a non considerare neanche le alternative meno main stream. Così rischiamo che i percorsi di formazione scientifica possano far diventare le persone più conservatrici di quanto sarebbero altrimenti.
Esistono dati o studi che danno un’idea della dimensione del fenomeno della discriminazione verso la comunità LGBTQ+ in ambito STEM?
Lo studio più completo finora è stato pubblicato a gennaio su Science Advances e riguarda il mondo accademico e scientifico statunitense. Il suo valore sta nel fatto di non considerare solamente le maggiori difficoltà che gli scienziati LGBTQ+ affrontano rispetto ai ricercatori non LGBTQ+, ma di guardare anche alle intersezionalità. Donne e persone nere della comunità LGBTQ+ subiscono maggiori discriminazioni rispetto agli uomini bianchi LGBTQ+. Questi dati ci fanno capire che l’unico modo per cambiare la scienza, e quindi la società in genere, è abbattere le barriere che affliggono diverse persone in modo diverso. Per esempio, a dieci anni dalla legge sulle quote di genere (la legge Golfo-Mosca del 2011, ndr) le donne non riescono ancora ad avere il giusto spazio nelle società quotate. Questo accade perché nel frattempo non stiamo facendo a sufficienza per abbattere le barriere.
Non credi che intervenire simultaneamente su entrambi i fronti sia più efficace? Pensando alle donne, eliminare le barriere che rallentano il loro ingresso nel mondo professionale vorrebbe dire più asili nido, congedo parentale per i padri e un cambio culturale nel modo di vedere le donne. Questi interventi richiedono molto tempo e in alcuni casi l’assenza di donne in certe posizioni ci impedisce anche solo di aspirare a certe carriere. In questo senso riservare dei posti alle donne in certi ruoli può essere più efficace nel breve periodo e contribuire anche al cambiamento nel lungo periodo.
Gli strumenti per mitigare i problemi causati da queste barriere sono certamente necessari, ma uno studio uscito il mese scorso su Nature Astronomy ha concluso che con le politiche attuali sulla parità di genere, sarà necessario aspettare il 2060 per vedere nelle università australiane un numero uguale di astronome e astronomi. Se, pur avendo introdotto delle politiche per la parità di genere, l’obiettivo non è raggiungibile prima del 2060, vuol dire che le politiche non sono abbastanza efficaci.
La battaglia per i diritti delle donne è forse quella più presidiata e visibile, almeno nel nostro paese. Può funzionare da traino per le battaglie per i diritti delle altre minoranze di genere?
Penso che le battaglie per i diritti vadano pensate in sinergia. La battaglia per una minoranza spiana la strada per quella delle altre minoranze. Un esempio può essere un ricercatore o una ricercatrice che rientra al lavoro dopo il congedo parentale. Se al suo rientro gli venisse permesso di dedicare più tempo alla ricerca che alla didattica, in modo da recuperare subito in termini di competitività, allora perché non fare la stessa cosa per le persone trans che decidono di avere chirurgia affermativa? Potremmo vedere che la stessa agevolazione può essere destinata a una persona che deve prendersi cura dei genitori o di un familiare disabile, e così via. Dovremmo vedere queste battaglie come una matrioska. In fondo, la maggior parte delle barriere sono molto simili e possono essere tutte ricondotte all’assenza di regole nel mondo accademico e nelle varie organizzazioni che diano alle persone la tranquillità di essere se stesse. Una volta che una battaglia è vinta per una minoranza, i benefici possono riguardare tutte le altre minoranze.
Quanto è importante indicare i propri pronomi di genere?
Penso sia estremamente importante. Da una parte ci sono motivi pratici. Per esempio, in un contesto internazionale è frequente non saper attribuire un genere a partire dal nome e quindi segnalare i pronomi con cui si vuole essere indicati serve a risolvere i dubbi. Dall’altra, è un modo per mettere a proprio agio coloro che non si sentono, o non si sentono ancora, a proprio agio con la loro identità. Chiaramente nessuno deve essere obbligato a farlo, ma credo che riflettere sull’opportunità di utilizzarli rappresenti di per sé un’occasione importante per accrescere la consapevolezza collettiva e culturale su questi temi.
Dopo aver ottenuto un dottorato in astrofisica all’Imperial College a Londra, dal 2015 lavori come giornalista scientifico e nel 2019 hai lanciato il podcast “The Astroholic Explains”, giunto alla terza stagione. Quanto è stata importante la tua esperienza di passaggio da ricercatore a comunicatore per il tuo percorso di attivista? Imparare a parlare di scienza a un pubblico non specializzato ti ha aiutato a trovare un linguaggio più inclusivo e capace di portare all’attenzione generale il problema delle persone LGBTQ+ nel mondo STEM?
Credo sia stata un’esperienza molto importante. Negli ultimi 15 mesi mi ha anche molto cambiato la discussione sulla decisione di vaccinarsi o non vaccinarsi. Sono stato abituato a un dibattito che tende a identificare chi non vuole vaccinarsi con coloro, spesso ricchi e in paesi occidentali, che decidono di non vaccinare i propri figli perché non credono nella scienza. In realtà, soprattutto qui nel Regno Unito, sono molto più numerose le persone appartenenti a minoranze etniche che non vogliono vaccinarsi o non vogliono che i loro figli vengano vaccinati perché non riescono a fidarsi di medici e scienziati per quello che hanno subito storicamente. Per convincere queste persone a vaccinarsi l’aggressione o lo scherno non sono certo i metodi giusti. Al contrario, bisogna essere disposti al dialogo, aperti a qualsiasi tipo di domanda. Questo, per me, significa fare comunicazione scientifica, cercare di raggiungere tutti. Se non si riesce a farlo, siamo noi comunicatori a dover interrogarci su cosa stiamo sbagliando e a impegnarci per migliorare.
Cosa pensi del dibattito politico sul DDL Zan e sul testo di legge alternativo proposto dai senatori Ronzulli e Salvini?
Rimuovere l’identità di genere dal DDL è un tentativo per dividere la comunità e coloro che ci sostengono, facendo finta che sia un’azione di compromesso. In realtà, questo approccio è lo stesso che sta seguendo il Partito Repubblicano negli Stati Uniti, e molti partiti di estrema destra in Europa e nel resto del mondo. Trump sarebbe orgoglioso di Renzi e Salvini. Sui diritti delle persone non si scende a compromessi.
Per ricevere questo contenuto in anteprima ogni settimana insieme a sei consigli di lettura iscriviti alla newsletter di Scienza in rete curata da Chiara Sabelli (ecco il link per l'iscrizione). Trovi qui il testo completo di questa settimana. Buona lettura, e buon fine settimana!